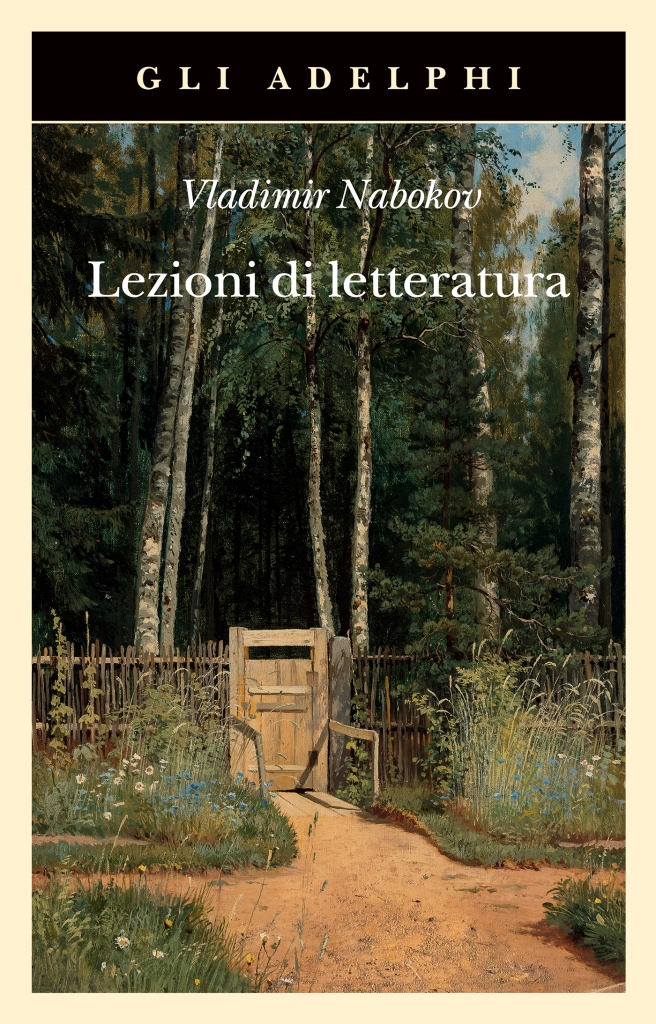Esistono, insomma, lettori migliori di altri?
A confrontarsi con Lezioni di letteratura di Vladimir Nabokov, proposto ora da Adelphi in edizione economica (gennaio 2022, traduzione di Franca Pece) le risposte sono indubbiamente positive, per esplicita dichiarazione dello scrittore, come vedremo più oltre.
Scrittore che tuttavia qui si presenta in veste di docente. Il volume raccoglie infatti le lezioni che hanno composto il corso di Letteratura Maestri della narrativa europea, tenuto da Nabokov alla Cornell University di Ithaca, dove fu Associate Professor dal 1948 al 1958.
Che la spiccata personalità di Vladimir Nabokov si declinasse anche in un’idea forte e oltranzistica di letteratura non ci ha stupito, come non potrebbe stupire nessun lettore che conosca l’opera dello scrittore russo naturalizzato statunitense.
A sorprendere, tuttavia, è quella che ci è parsa una giustapposizione un po’ spericolata di intuizioni folgoranti e grossolane affermazioni arbitrarie.
Vorremmo qui aggiungere che questa nostra recensione dal piglio diverso dal solito si è resa quasi necessaria, giacché è lo stesso Nabokov – esibendo una piena sicurezza nel definire quali siano le letture corrette e, dunque, i lettori avveduti – a chiamare a un’adesione o a un rifiuto della sua intransigenza.
Va da sé che un grande scrittore debba essere altresì un lettore finissimo. E Nabokov lo dimostra in svariati passaggi del libro. Ad esempio, parlando di Madame Bovary egli è capace di vivisezionare lo stile di Flaubert (corsivo nel testo): “Flaubert usava una tecnica speciale che potremmo chiamare metodo del contrappunto, ovvero la tecnica di spezzare con interruzioni e inserimenti paralleli due o più conversazioni o flussi di pensiero” (p. 224). O, ragionando sulla differenza di stazza tra il Jekyll e l’Hyde di Stevenson (che pure, come ben noto, sono una medesima persona), giunge a notare che: “Jekyll non si trasforma in Hyde, ma proietta un concentrato di pura malvagità che diventa Hyde, il quale è più piccolo di Jekyll, un omone, per indicare la maggior quantità di bene di quest’ultimo” (p. 268).
Ma ecco che l’estrema fiducia di Nabokov nella propria acutezza di lettore (e di scrittore) lo porta a confondere la letteratura con un grande enigma, il cui scioglimento sarebbe alla portata dei più abili solutori.
Già ci pare che strida, per eccesso di sicumera, quanto dichiarato a proposito di Casa desolata di Charles Dickens: “Nel leggere il libro occorre fare attenzione ad alcune cose” (p. 120). A cui segue un elenco numerato di sette argomenti che secondo Nabokov non possono non essere considerati per la piena comprensione del testo.
Sempre parlando dell’opera di Dickens, ma pronunciando una sentenza universale, Vladimir Nabokov scrive: “Quale duplice impressione ci comunica un grande capolavoro (per «ci» intendo ai buoni lettori)? La Precisione della Poesia e l’Emozione della Scienza” (p. 194). Dove, se ci pare discutibile la seconda parte della frase, è nella prima che si introduce l’ancor più pericoloso concetto, anzi la figura, dei buoni lettori.
Figura che torna nell’ultimissima pagina del volume, in cui lo scrittore e docente prende commiato dai suoi studenti: “In questo corso ho cercato […] di farvi diventare buoni lettori che leggono i libri non con lo scopo infantile di identificarsi con qualche personaggio, e non con lo scopo accademico di indulgere alle generalizzazioni” (p. 522).
Noi ci permettiamo invece di credere che non esistano lettori buoni e meno buoni. Che non esistano, insomma, lettori privilegiati. Che, per quanto uno scrittore possa avere in mente il proprio lettore modello; per quanto un’approfondita conoscenza – ad esempio – del contesto storico e sociale in cui si muovono i personaggi di un romanzo possa suscitare nel lettore un’immaginazione più precisa, compiuta e magari più aderente alle intenzioni dell’autore rispetto a quella di chi sia totalmente ignaro di ciò di cui sta leggendo; e infine per quanto la mancata intercettazione di citazioni e rimandi più o meno espliciti possa limitare dal punto di vista quantitativo i motivi del godimento estetico; per quanto tutto ciò sia plausibile, la letteratura non è una meta destinata solo ai lettori più atletici.
Bensì un luogo di parità, in cui le sensazioni e le emozioni di un lettore valgono quanto quelle di un altro. Se così non fosse, la letteratura non sarebbe quell’invenzione eterna, tesa al raggiungimento della chiarezza assoluta, che proprio nella sua eterna tensione mostra la misura di un’irrimediabile distanza dall’obiettivo, equidistante in ogni epoca e latitudine. Ed è esattamente lì che risiede la sua altrettanto eterna meraviglia.
(pubblicato su Squadernauti l’11 marzo 2022)