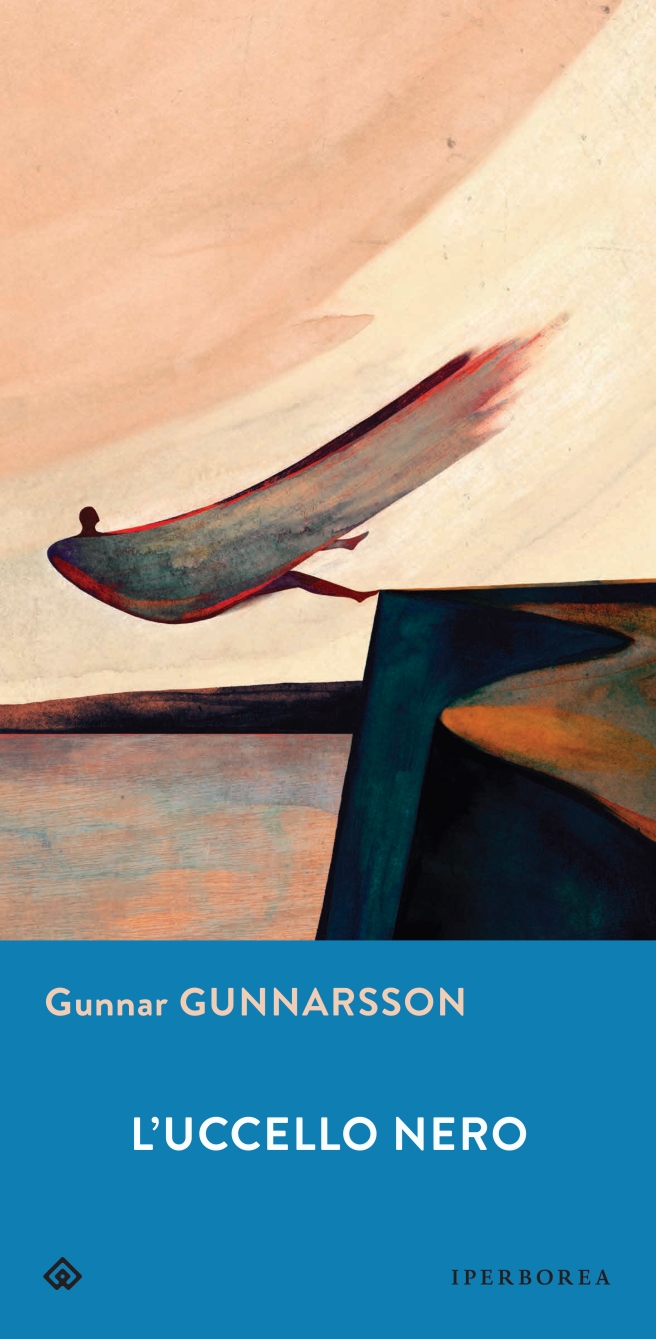Il romanzo era già apparso in Italia per Mondadori nel 1936, tradotto da Giacomo Prampolini. Gunnarsson lo ha pubblicato in Danimarca, dove risiedeva, nel 1929: scritta in lingua danese, l’opera sarebbe poi stata tradotta in islandese dallo stesso autore una volta fatto ritorno in patria.
L’uccello nero viene eletto forse un po’ arbitrariamente a capostipite del noir scandinavo, e di certo ha contribuito alla sua notorietà la dichiarazione di Ernest Hemingway, che lo considerava una delle sue letture favorite.
Al di là di classificazioni e sponsor, a noi pare che il libro sia soprattutto una profonda ricognizione su libertà, giustizia, colpa ed espiazione; e l’elemento giallistico, tenue, è cornice e non centro della narrazione.
Siamo nel diciannovesimo secolo. A Syvendeaa, una fattoria isolata di un villaggio islandese, vivono due coppie: l’energico Bjarni con la cagionevole Guðrun, il rozzo Jón con la bella Steinunn.
Dopo la misteriosa e macabra morte di Jón, si diffondono le voci di una relazione tra Bjarni e Steinunn. In breve tempo, Guðrun sarà trovata morta avvelenata, e i due sospettati di adulterio diventeranno i principali indiziati di entrambe le scomparse.
A narrare la storia, e a essere coinvolto come testimone nel processo a carico dei due presunti amanti-assassini, è il giovane cappellano Eiúlvur, lacerato tra i desideri di giustizia, pietà e verità. E cioè tra l’obbedienza alla legge, alla moralità e a Dio.
Basato su un fatto di cronaca, L’uccello nero ha nello scabro paesaggio islandese un ambiente privo di distrazioni, di ripari: tutti i personaggi sembrano quindi intrappolati nella fissità delle loro convinzioni e dei loro destini.
Inoltre i grandi spazi, assieme ai ritmi lenti e uguali della natura, in qualche modo incarnano agli occhi di Eiúlvur (cui sarà affidato il conforto spirituale dei due imputati) il significato di colpa e responsabilità, nucleo dei suoi struggimenti.
“A vedere le mucche che avanzavano nel gelo e nella neve mi si strinse il cuore, e quelle pecore che si trascinavano avanti avevano qualcosa di precario e malinconico, come se insieme a loro si allontanassero per sempre, da Bjarni e da Syvendeaa, gli ultimi resti di quello che era stato una casa e una speranza.
E io, che le guardavo passare, non avevo forse una parte decisiva in quanto stava accadendo? E quel che era peggio: potevo assolvermi dal senso di colpa per gli eventi oscuri e misteriosi per cui ora le bestie di Bjarni mi passavano davanti in una direzione, mentre lui, privo della sua libertà, veniva portato via nell’altra?” (p. 102).
Un senso di inevitabilità aleggia sul processo, ben rappresentato dalla mancanza di scrupoli del giudice: “«Sai una cosa, mio buon cappellano?» disse, agitando le spalle magre come per scrollarsi qualcosa di dosso. «Sono quasi giunto alla conclusione che le fantasie e i sospetti cresciuti intorno a questo crimine sono più orribili del crimine stesso. Solo una cosa può cancellare i pensieri cupi e gli incubi che hanno risvegliato. Quei due devono morire! Direi quasi: che abbiano ucciso o no!»” (pp. 193-4).
Il tormento del cappellano deriva dalla sua strenua volontà di contrapporre ai pregiudizi una verità che sia tale sul piano della giustizia sia umana che divina. La fedeltà a questo suo compito lo strazierà (“La verità! Non era anch’essa uno degli avvoltoi neri, rauchi e voraci dell’esistenza? La sua legge non era la stessa che domina sul resto della vita? Procreare e distruggersi…”, p. 198), e lo farà definire da Bjarni “amico terribile” (p. 208).
E la verità, che Eiúlvur intravede dopo un colloquio con Steinunn, trascende gli ambiti del processo: è quella, universale, dell’impossibilità di sottrarsi al male, per quanto compiuto da altri, e di dichiararsi estranei a ogni delitto che avviene nel mondo.
L’uomo, sembra dirci Gunnarsson, è destinato alla colpa, poco importa se propria o altrui. Colpa alla quale può opporre solo la misericordia: “La lasciai rabbrividendo. C’era nelle sue parole come un presagio funesto. Qualcosa che mi riguardava. Una profezia oscura… Solo il fatto che mi avesse chiamato per nome… Il suo destino – il corso che aveva avuto e che avrebbe avuto in futuro – mi riguardava. Era intrecciato con il mio! Forse i destini di tutti gli uomini erano intrecciati? Ed era cieco chi non lo vedeva? Ottuso chi non lo sentiva? Sì, era così! A un tratto lo capivo. Ed ero lì, in mezzo al buio minaccioso e infinito, in mezzo al sangue e all’orrore, al martellio assordante di cuori traviati…” (p. 254).
(pubblicato su Squadernauti il 22 settembre 2021)